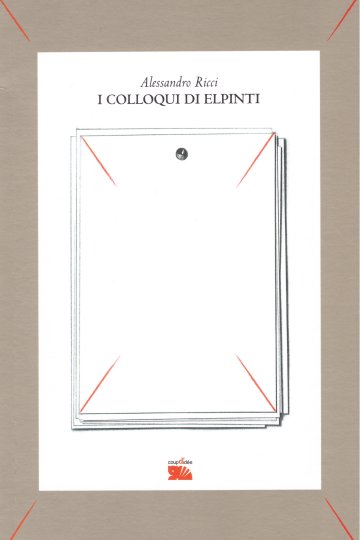Project Description
I colloqui di Elpinti, Alessandro Ricci
A quasi vent’anni, ormai, dall’inizio del nuovo secolo si sta iniziando a capire che certe gerarchie non sono indiscutibili. Nel Novecento, si sono date esperienze poetiche tuttora semi-sconosciute, che sono degne di essere collocate al livello della migliore letteratura rubricata dalla critica accademica e dalla storiografia “ufficiale”. Il caso straordinario di Alessandro Ricci, poeta altissimo e negletto, è esemplare…
Ci sono degli autori che sembrano fatti apposta per rimanere nell’ombra. E non essere quasi neanche letti, per il tempo breve della loro vita (che in letteratura è un tempo piccolo, assai poco significativo). Con la conseguenza, giocoforza, di non risultare per nulla “influenti” sulle generazioni immediatamente successive alle loro, nel senso, perlomeno, in cui la critica di solito ragiona d’influenza, questo prodotto ambiguo della bilancia quantitativa. Di tanta discreta genia di scrittori inattuali in forte credito di stima, Alessandro Ricci è senz’altro uno dei campioni più dotati. Per molti motivi, che possono essere ridotti, insomma, a due: per la novità e la potenza di rappresentazione, e la forza simbolica ed espressiva di tanta parte di ciò che ha concepito. “Poeta vero, molto raffinato, forse troppo lucido”, come pare ne abbia detto un lettore dell’acume di Giorgio Caproni, Ricci (Garessio, Cuneo, 1943 – Roma 2004) nell’ultimo trentennio del secolo scorso ha scritto poesie quasi sfacciatamente fuori tempo, estendendo la sua visione tragico-esistenziale essenzialmente contemporanea a una temporalità passata acquisita come storica. I suoi versi li ha scritti in un “modo” strano e molto raffinato, appunto, esercitando il suo virtuosistico talento del dettaglio per vie di minimi scarti tonali fra narratività e lirismo. Il che, va da sé, non dice nulla su ragioni e sragioni della sua quasi totale invisibilità, e della pesante cappa di silenzio che è calata per così dire fin da subito sulla sua opera. Ma il fatto è che Ricci era un uomo schivo e appartato, tutt’altro che presenzialista, senza smanie napoleoniche da “primo della classe” né voluttà di auto-rappresentazioni esagerate; un uomo, dunque, fin troppo schivo e appartato, per ambire a salire da protagonista sul proscenio pieno di fantocci sgomitanti della società dei poeti. Eppure, non si fa opera di coraggio critico nell’affermare, come faccio, che è (stato) un poeta fra i più notevoli della seconda metà del Novecento, in Italia. Anche se quasi nessuno se ne è accorto. Può bastare la lettura di Gli ibis, a dar evidenza della levità e dell’eleganza ritmico-prosodica del suo dettato, e della malinconica felicità immaginativa di una mente che era capace di “accendersi” di fiamma d’amore di fronte alla memoria di un mondo amato e perduto sì, eppure vivo e presentissimo.
Gli ibis
Lo schiavo sudanese del porto
di Massilia, sfinito dai pesi
e dalla sferza, vede calare
dall’oneraria un mazzo convulso
di ali e becchi nella rete,
e sono atrocemente,
fra le risate della ciurma,
ibis rossi della Nubia.
Per gli eleganti horti dei capi
trascinati fin qui.
Lui che li vide accendersi
nei canali, e volare sui loti
e le canne in lente
file al crepuscolo, o intuìti
altissimi sulla savana, numi
in quella terra felice.
Aveva forse dieci anni.
Quella gran polvere all’orizzonte.
Chi diceva antilopi dalla Libia,
invece apparvero le coorti nùmide
che l’avrebbero preso.